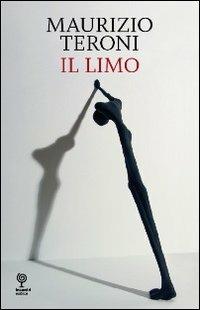Rosaria Lo Russo (Firenze, 1964), poeta, performer, traduttrice, saggista. Ha pubblicato L’estro (Firenze, Cesati, 1987), Vrusciamundo (Porretta Terme, Il battello ebbro, 1994), Sanfredianina, in Poesia contemporanea. Quinto quaderno italiano (Milano, Crocetti, 1996), Comedia (Milano, Bompiani, 1998), Dimenticamiti Musa a me stessa – con sedici disegni di Renato Ranaldi, (Prato, Edizioni Canopo, 1999), Melologhi (Modena, Emilio Mazzoli, I Premio Antonio Delfini 2001), Penelope (Napoli, d’if, 2003), Lo dittatore amore. (Melologhi, Milano, 2004 (libro + cd), Crolli (Trieste, Battello Stampatore, 2006, Anteprima di Crolli, con un’opera di Renato Ranaldi (Firenze, Le Lettere, 2012), Io e Anne. Confessional poems, (Napoli, d’if, 2010 – libro + cd), Nel nosocomio (Massa Carrara, Transeuropa, 2011), Poema (1990/2000), (Arezzo, Zona, 2013). E’ presente in numerose antologie poetiche. Ha tradotto la poetessa statunitense Anne Sexton e la poetessa argentina Alfonsina Storni. Insegna lettura di poesia ad alta voce. Da oltre vent’anni si propone in pubblico come “poetrice”, poetessa-attrice e esperta nell’arte oratoria e nella recitazione della poesia.
Teroni
Mi pare che la veste ideale per le tue poesie sia la performance, ovvero qualcosa che prevede una recitazione pubblica e quindi si distingue dalla poesia letta, diciamo, in una dimensione solitaria. Ti chiedo semplicemente: qual è il motivo di questa scelta?
Lo Russo
Sicuramente è così. Il motivo affonda, diciamo, negli inizi, perché agli inizi della mia vita, già nell’infanzia ma poi sempre di più dall’adolescenza ero amante dell’arte, venivo portata spesso da mio padre a teatro o a vedere mostre; ma la mia prima grande passione è stata il teatro. Il teatro come luogo in cui dal buio esce la parola, dalla luce esce la parola, dal luogo, dalla persona fisica, però in una dimensione isolata, esce la parola.
Quindi la parola davanti a un pubblico viene da un isolamento, da una tragedia maggiore di quella lirica della pagina che non sempre innesca lo stesso effetto, mentre il teatro in qualche modo è sempre tragico, c’è sempre una persona inerme che si espone. Sicuramente la mia poesia è al fondo di tutto quella di una voce inerme che si espone, per di più per ingaggiare una lotta, quindi inerme, senza armi, ma per un moto ostinato di ribellione.
Una voce inerme e un’ostinata ribellione… Ed è ancora così?
Sì. Questo non è mai cessato di essere così dall’inizio e questo non esclude la gaiezza, non esclude la giocosità, anzi, si serve anche di una certa rumorosità, di un’energia anche eccessiva, che talvolta è stata definita barocca, è una modalità che ha l’imprinting di ciò cui ho assistito in età molto giovanile, a spettacoli molto forti; ho visto da molto giovane il teatro di Tadeusz Kantor, di Lindsey Kemp, di Carmelo Bene e, sin da piccolissima, andavo ogni anno al circo. Il circo è per me un posto mitologico. Il miracolo dell’arte accade lì! In quella commistione di sublime e osceno. Come accade nel circo, nel teatro, accade nel cinema di Totò, nelle tecniche geometriche e folli del vaudeville, del varietà, lì è, o era, in atto, la verità mostruosa e sublime dell’arte. E poi, grandiosamente, nell’opera lirica… da molto piccola, poi per tutta la vita, ho assistito all’opera lirica. Che fortuna avere una famiglia di melomani. Ecco, la dimensione che accade nella mia mente, quando si accende una poesia la mia testa diventa un teatrino con queste varietà possibili dall’estrema delicatezza al casino del Luna Park (altro luogo pieno di arte).
La domanda che mi viene ovvia da porti è, se amavi il teatro, la forma recitativa, perché hai scelto la poesia e non direttamente il teatro?
In realtà io, a 14 anni scribacchiavo delle poesie, però era iscritta a una regolare scuola di teatro, che ho frequentato fino a 18 anni. Tecnicamente sono un’attrice fallita. Diciamo però, che il caso volle che questa scuola di teatro, molto ben condotta da mio maestro Paolo Coccheri, avesse una meritevole abitudine, quella di fare ogni domenica mattina dei reading di poesia, in cui spesso venivano inviatati i poeti che avremmo letto, almeno quelli che in quell’epoca erano ancora vivi, attivi a Firenze, i poeti ermetici Bigongiari, Luzzi, Parronchi, io li ho conosciuti tutti, poi nella mia lunga vita di performer di poesia, ho conosciuto poeti ancora più importanti, ho letto alla loro presenza, premi Nobel come Brodsky, come Szymborska e decine e decine di altri, Giorgio Caproni per esempio, al gabinetto Vieusseux di Firenze. Io di fatto faccio più la lettrice di poesia che la poetessa quantitativamente, anche se ormai diciamo abbiamo quasi pareggiato i conti, poi verso i sedici anni ero lanciatissima nel teatro comico, cioè era molto brava, avevo i cosiddetti tempi comici, quindi mi volevano prendere nella famosa Compagnia della Rocca, che allora era una compagnia molto importante di teatro nazionale, perché ero molto cicciotta, sfrontata, sfacciatissima, molto buffa, recitavo molto bene Feydeau, ma purtroppo ero minorenne e non se ne fece di nulla.
E poi che accadde?
Poi, purtroppo, a 18 anni ho avuto il primo di una lunga serie di esaurimenti nervosi, che si sono manifestati innanzitutto con attacchi di panico, e dunque ho dovuto smettere di recitare perché mi venivano gli attacchi di panico un po’ in generale ma uno mi è venuto proprio durante l’ultimo provino (di ben 5, e ne avevo superati 4…) che dovevo sostenere per entrare nella scuola di Gassman, che allora era a Firenze nella sedia santa Maria, in Oltrarno, dove da ragazzina avevo assistito a La classe morta e Wielepole, Wielepole di Kantor. Indimenticabile il profilo immobile di quel regista mentre assisteva alla recita dei suoi attori formidabili…. Avevo superato tutte le prove, poi mi trovai di fronte Vittorio Gassman (che era altissimo, bellissimo, famosissimo, torreggiante) e mi dimenticai tutta la fuga di Saba che avevo portato, che è un classico incubo dell’attore, mi dimenticai tutto, il vuoto, il buio… è anche un sogno che ho fatto, ricorrente, molto fantozziano, quello che entro in scena e mi dimentico tutto.
Non deve essere semplice mettersi così in gioco. Come hai affrontato in seguito questa paura?
E’ stato per me determinante il mio migliore amico, il compianto drammaturgo Massimo Sgorbani, con cui ho collaborato moltissimo, ho fatto del teatro con lui in età avanzata, una prima volta con un testo mio, dove però l’escamotage anti-panico è stato registrare il testo, cioè non recitarlo dal vivo; in scena, facevo solo azioni performative, movimenti, e questo s’intitolava Racconto d’infanzia, l’ho fatto una volta a Firenze, una volta a Bologna, poche volte, perché poi non sono mai entrata nel circuito del teatro, e poi qualche anno fa, ho fatto la parte di Pappagallino, questa volta a memoria, prendendo litri e litri di benzodiazepine, prima di entrare in scena. Facevo il Pappagallino della famiglia Pampurio, in questo spettacolo bellissimo di Massimo Sgorbani che s’intitolava Salò e le centoventi giornate di Sodoma. Facevo un pappagallino che recitava poesie di D’Annunzio e Malaparte. Però, a un certo punto, Pampurino, il figlio, si scoccia dell’uccello che recita versi e gli spara e lo ammazza. È ovviamente tutta una simbologia antifascista. Questo fu scritto appositamente per me, perché io ho una passione sviscerata per i pappagalli, infatti ne ho 4… Quindi Massimo, essendo un amico molto intimo e che abitava spesso a casa mia, ha scritto per me la parte del Pappagallino. Dunque sono un’attrice mancata, e mi manca sempre quella cosa, perché le emozioni avute a teatro, nella mia vita sono fortissime, non minori ormai di quelle della poesia ma, insomma, diciamo che la poesia era seconda per me rispetto al teatro. Ora non ne vedo tanto la differenza, perché io, fondamentalmente, la poesia la intono, non la recito, la canticchio. Ieri ho dato voce a Forugh Farrokhzad, la cui poesia è talmente immensa che molto teatro contiene, come molto di tutto del resto. Poi, in effetti, per secoli il teatro è stato principalmente scritto in versi.
Certo che, per una persona che soffre di attacchi d’ansia, fare la scelta di esporsi pubblicamente è strana.
Diciamo che ho lottato disperatamente per superare questa cosa, perché comunque è la cosa che mi piace di più da sempre. Quindi volevo combattere gli attacchi d’ansia perché mi negavano una cosa che dovevo fare per esistere. Ma ora non mi vengono più. Cioè, quando ho fatto Pappagallino, che era nel 2016 e ho fatto 20 e più repliche, ho deciso che non avrei fatto più poi esibizioni a memoria. Se ci fosse stata una tournée avrei lasciato la parte a qualcun altro. Però i reading, se io ho lo scudo del leggio e l’arma del microfono, allora non temo nulla, preservo il mio isolamento visionario, che difende l’esibizione dall’esibizionismo, caratteristica della recitazione mediocre, che odio. Perché poi è chiaro che l’ansia è un temere il giudizio; è una forma di insicurezza caratteriale, dovuta alla mia storia, ma è anche una convinzione del valore della voce in sé. Forse perché avevo anche da scrivere…
Immagino sia un problema che riguarda chi si trova di fronte a un pubblico, soprattutto per chi recita a teatro.
Gli attori sono diversi; ne conosco tanti, sono diversi dai poeti. Ci sono stati tanti poeti-attori, poeti-scrittori, scrittori-attori… la cosa è sempre conflittuale. Anche Carmelo Bene scriveva; faceva di tutto. Ci sono attori che invece sono pacificati con il loro narcisismo, con il loro godimento di esibirsi. Io non ho mai inteso tutto questo come esibizione, ma come esposizione, quello sì, come esposizione del cadavere di Io, l’esibizione di Me. Sono più una performer che un’attrice. Sono la Morta che Parla, una maschera, una figurina della Smorfia. Anche Pappagallino era una parte scritta per questo me, parlava di me, della mia esibizione-esposizione-espiazione. Della catarsi volatile di chi lavora col linguaggio e la voce.
In questo modo, la poesia che viene recitata, assume una forma che va interpretata. Voglio dire che gli si dà un’impostazione già interpretativa in questo modo. In questo modo si lascia forse il lettore interpretare le parole secondo proprie prospettive. Sei d’accordo?
No. Perché il tempo del reading è di solito 20/25 minuti; poi il lettore ha tutto il tempo di leggere le cose da solo. Io quando faccio i reading non è che leggo tutto; leggo qualcosa. Non è una vera e propria interpretazione; è più una intonazione. Io chiamo il mio modo di fare reading performance una voce critica. Ripenso a una frase di Fabrizio Frasnedi, in un suo saggio su “Il Verri” di tanti anni fa: “la voce è un filologo intuitivo”. Ecco, io spero, ce la metto tutta, di fare questo. Un mio reading è un mio punto di vista sonoro sul testo, sapendo che un testo ha infiniti punti di vista sonori possibili, come ogni partitura metrico-ritmica, fono-ritmica.
Non è quindi un recitare qualcosa come dargli una forma definitiva, ma è un approccio simile a quello di un esecutore che affronta uno spartito; che sa benissimo che la sua sarà una possibile interpretazione, sia a livello di coloriture, sia a livello di ritmo, di quel brano. La mia esibizione è dunque anche una esecuzione capitale, mi gioco la credibilità filologica. Anche quando il ritmo in certi casi è obbligato, quando per esempio la poesia è in metrica. Però disprezzo quegli attori che pensano di dire la verità sul poeta mentre leggono una sua poesia. Io non sopporto gli attori che leggono la poesia, perché loro sì la leggono come se fosse una verità rivelata, uno scoprire gli altarini del povero infelice, il poeta, la poetessa magari, che solitamente è suicida. Non è così il mio reading. La bocca è sempre atteggiata a sorriso, a apertura. Ogni poesia è immensamente felice. Ogni poesia è inno alla gioia, anche semplicemente di cagare. Comunque internet è pieno di miei reading. Si può anche fare il confronto. Io creo degli spartiti vocali.
Prima mi dicevi che, quando scrivi, pensi a un linguaggio estroverso, recitato. Giusto?
No, non lo penso, perché ti dicevo che la mia mente quando produce poesia, è un teatro, di solito chiuso, buio freddo e polveroso, un teatro all’italiana chiuso da tempo in attesa di essere aperto. È un teatro della mente fatto così; non è che io penso cosa voglio dire al pubblico. A un certo punto qualche luce si accende, qualcosa succede. Magari passa solo un topino e si alza un brillio di polvere. Perché non è un teatro con tutti i lampadari accesi sempre e io non sono fondamentalmente un’attrice. Io non voglio dire niente al pubblico. Io cerco qualcosa che prenda vita, cerco un’espressione che accenda una lucina; cerco di fare qualcosa di vivente con il linguaggio, ma di vivente nella dimensione di quella che per me è la cosa più vicina alla verità, la finzione dell’offertorio dissacrato del circo, del teatro, dei buffi.
Però mi sembra che i tuoi testi abbiano dei contenuti spesso forti; non sono testi giocosi, nel senso che non sono impostati, che so, sul meccanismo fonetico o retorico o metrico. Sono pieni di significato.
Certo. Però… non nasce prima l’uovo o la gallina. Non c’è un’intenzione di imbonire o di scandalizzare l’ascoltatore. Accade quello che accade. È un teatro interiore. Il teatro può essere un teatro di guerra, un teatro della rissa; il teatro è un luogo dove si compone un certo discorso. Visivamente c’è un pubblico che lo guarda, ma la poesia si rivolge a un “tu”. Io mi rivolgo a un “voi” più che a un “tu”. Più a una pluralità, a volte un “noi”, a volte un “tu”. Io non sono “io”. Il discorso dell’io passa attraverso un medium letterario e soprattutto performativo. C’è la letteratura e il mondo dello spettacolo. Il rapporto è con la letteratura e lo spettacolo. C’è però una cosa importante da dire: io leggo a alta voce in pubblico molto di più testi di altri che miei. E non distinguo le due attività di scrittura in versi/lettura in versi. Creativamente non le distinguo. Non è che dico: ora scrivo una poesia o leggo la poesia di un altro. “Faccio poesia” in queste due modalità e con il doppio fondo della letteratura e dello spettacolo. Da non confondersi assolutamente con lo spettacolo della letteratura, che aborro o della letteratura spettacolo, che aborro. La finzione di cui parlo è il contrario dell’impostura. Spettacolo della letteratura e letteratura spettacolo sono imposture, prodotti commerciali.
Ci sono, secondo te, poesie più adatte ad essere messe in scena e altre meno?
“In scena” non è un mio termine… “in voce”. “In scena” è il teatro; non è poesia.
Diciamo che la prova della lettura a alta voce è la prova del nove per la poesia. Se la poesia è brutta, scritta male, superficiale, crolla alla prova della voce. Anzi, è un’ottima prova scrivere ad alta voce; perché la voce è spietata. Poi ci sono dei poeti, anche stimabili, che in qualche modo non tollerano il volume. Se dovessi “fare” Sbarbaro, dovrei andare in uno studio di registrazione e bisbigliare. In una sala, anche con un microfono ad altissima qualità non lo saprei fare; lo stesso vale per Montale, che in qualche modo in questo è tanto sbarbariano. Perché ogni poetica ha un suo volume. Alcune non tollerano un volume normale. Vengono proprio depauperati, offesi. Poi ci sono poesie solo cerebrali; per esempio quella di Pasolini, il quale utilizza una terzina dantesca che non suona, è volontaristicamente dantesca ma non nella carne del linguaggio. Io sono una che ha sempre letto Dante in pubblico, e anche tanto. Sono stata chiamata una volta a leggere Le ceneri di Gramsci, libro ovviamente rispettabilissimo. Leggere ad alta voce Le ceneri di Gramsci è un disastro. Non funziona.
Perché non funziona?
Perché è una terzina dantesca imposturata; è una terzina dantesca che non nasce dalla necessità del corpo vocale (la voce è deiezione corporale). Queste cose io le sento e non riesco. Perché mettere in voce è un atto creativo analogo a scrivere. Se fossi un’attrice lo farei, in un modo o nell’altro. Non essendo appunto un’attrice, se una forma metrica non è ben sposata con la sintassi, per dire, non riesco a cantarla. Non canta. E quindi ci sono dei poeti, per me, impossibili da mettere in voce. Ti ho detto quali e ti ho detto perché, però sempre per motivi testuali, mai biografici. Il testo è molto più importante di quello che posso fare io; il testo è il regista. Per esempio, “La libellula” di Amelia Rosselli, che io ho fatto in versione integrale decine di volte in pubblico, è adattissima a essere letta a alta voce, anzi recitar cantata. Lei lo sapeva, in quanto musicista, e lo dice esplicitamente in più luoghi che questo testo “è rivolto a una folla immaginaria”, cioè mentre lo scriveva aveva in mente un gran teatro aperto. Mentre altre cose della Rosselli, si leggono bene a voce alta, ma non è per loro indispensabile. E Montale, invece, non funziona, perché è una poesia-pensiero, che cita la lirica del Duecento fiorentino come un ricordo non come una cosa che riaccade, come una citazione, tranne qualche immenso testo de La bufera e altro….
Il gioco della torre
Hai avuto un invito per una breve vacanza al mare da un’autrice del passato. Potrai passare due giorni con lei e confrontarvi su tante cose, tra cui la poesia. Chi sceglieresti tra Alda Merini e Anne Sexton e perché?
Anne Sexton, perché è la mia migliore amica da trent’anni! Ironica, sexy, simpaticissima. Unico problema, io astemia… cosa fare durante le sue sbronze? E di poesia poi non parlerei vorrei piuttosto sentirla leggere la sua poesia, ma anche quella di Hopkins, di Dylan Thomas. E vorrei traducesse una mia poesia, o meglio un poemetto!