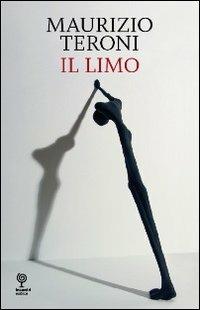Vito M. Bonito (Foggia 1963), vive a Bologna: ha pubblicato Acrobeati (La Vita Felice, 2023); Lo zecchino d’auro (Blŏnk, 2023); Papaveri per niente e teatrino de li papavera (Derbauch, 2021); Di non sapere infine a memoria 1978-1980 (L’arcolaio, 2021); fabula rasa (Oèdipus, 2018); La bambina bianca (Derbauch, 2017); Soffiati via (Il Ponte del Sale, 2015 – premio Nazionale Elio Pagliarani 2015); Luce eterna (Galerie Bordas Venezia, 2012); Fioritura del sangue (Perrone, 2010); La vita inferiore (Donzelli, 2004); Campo degli orfani (Book, 2000); A distanza di neve, Book, 1997. È presente in Poesia contemporanea. Quinto quaderno italiano, a cura di Franco Buffoni (Crocetti 1996); in Parola Plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, (Sossella 2005); in Alberto Bertoni, Trent’anni di Novecento. Libri italiani di poesia e dintorni 1971-2000 (Book 2005). In ambito critico sono usciti i volumi Le parole e le ore. Gli orologi barocchi: antologia poetica del Seicento, Palermo, Sellerio, 1996; L’occhio del tempo. L’orologio barocco tra letteratura, scienza ed emblematica, Bologna, Clueb, 1995; Il gelo e lo sguardo. La poesia di Cosimo Ortesta e Valerio Magrelli, Bologna, Clueb, 1996; Il canto della crisalide. Poesia e orfanità, Bologna, Clueb, 1999); Pascoli, Napoli, Liguori, 2007. È tra gli autori dell’antologia Poesia del Novecento italiano (vol. II), a cura di N. Lorenzini Roma, Carocci, 2002. Ha scritto inoltre saggi su Montale, De Signoribus, Beckett, Artaud, la Socìetas Raffaello Sanzio, Aristakisjan, Herzog e Korine. Da ultimo ha curato (con Jacopo Galavotti e Giacomo Morbiato) il volume di Cosimo Ortesta, Tutte le poesie, Argo Libri, 2022. Di Soffiati via è uscita la traduzione inglese Blown away, a cura di Allison Grimaldi Donahue, Fomite Press, Vermont, 2021. È redattore della rivista Versodove.
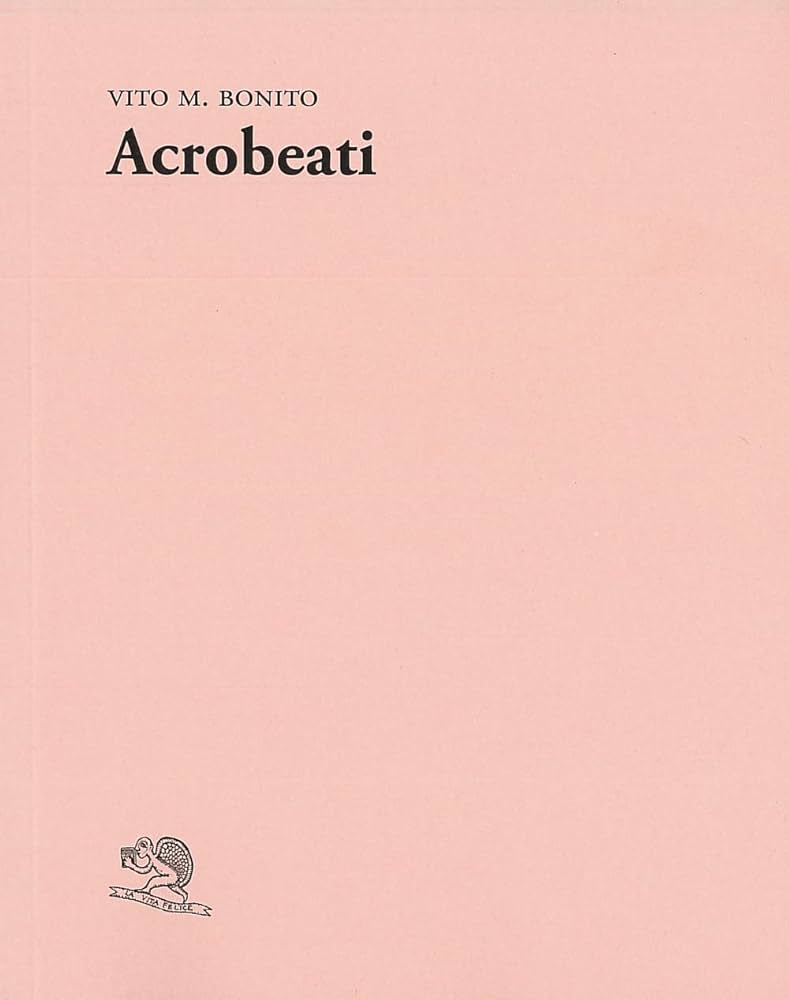
Teroni
La domanda da cui voglio partire è la seguente: tu credi nella ispirazione?
Bonito
Sì, assolutamente sì, se ovviamente a questa ispirazione diamo la forma meno classica e stereotipata possibile. L’ispirazione ha mille forme, passa in ogni canale disponibile, si autoinstalla senza chiedere permesso; e soprattutto non parla mai la stessa lingua. Fidelizzarsi a una sola ispirazione non è utile. Per me è stata sempre una ininterrotta seduta spiritica, e lo è ancora. Nondimanco le voci dei morti, dei fuggiti, dei non-nati, dei perduti sono diventate negli ultimi anni gli acufeni, le balbuzienti vocalizzazioni che ho iniziato a sentire nei termosifoni, tra gli stipiti delle porte. Questa è addivenuto e diviene nella mia dismisura ispirativa e inspirativa. Innanzitutto è l’ascolto, una dimensione acustica dentro la quale io, a un certo punto, mi trovo, cado e accado. Il tutto sta a cogliere le voci anche sgrammaticate di queste presenze, i loro bisognini, i gridii, gli inframezzi abrupti con cui infestano la lingua. Sono illuminazioni perentorie, pervicaci – lampadine ripiene di pupazzetti che si accendono, e poi ciao.
Tre anni fa, a un certo punto, non so perché, mi è apparso un mio vecchio compagno di classe delle elementari che mi parlava. Appena questa apparizione sonora e in qualche modo allucinata si è avverata, si sono accesi i termosifoni. Quindi ho legato questi due eventi ad una presenza, diciamo, “altra”, uno stato immateriale che mi possedeva a distanza. Così mi sono messo ad ascoltare i termosifoni. Lo dico perché, innanzitutto, è vero; inoltre, perché questo mi permette di entrare in una dimensione di rovesciamento del ‘poetico’ a cui in qualche modo ciascuno di noi fa riferimento. È una pedagogia rovesciata che impone una ferrea retorica della maniera posturale e linguale. Si devono auricolare i gorgoglii, i borbottii del termosifone, i sentimenti della caldaia, gli appilamenti del lavandino, gli sfrigolii dei neon. Questa è la mia, come dire, musa idraulica, o meccanica o calorifera.
I morti mi fanno pensare al freddo, i termosifoni al caldo.
Sì, in qualche modo: appunto per questo dicevo anche un rovesciamento, perché, paradossalmente, è da una dimensione notturna o comunque fredda (nell’immaginario certo il mondo dei morti è anche qualcosa di freddo), si passa ad una presenza calorifera, radiata (“l’estate fredda dei morti” direbbe Pascoli) che ovviamente capovolge, sovverte, come dire, la meccanica del funzionamento. Insomma, per intenderci, si è passati, come dire, dalla tragedia o dall’elegia, al comico (se per comico intendiamo persino la beatitudine, la beanza). Quindi il calorifero porta il comico, sia dal punto di vista linguistico soprattutto, sia dal punto di vista delle cose che mi fa dire. Messo in moto il marchingegno delle apparizioni, liberatomi dall’ingorgo del voler dire, finalmente qualcuno o qualcosa si dice: che siano i soppravvivi delle scuole elementari, o fulgidi fantasmini come Piccolo Tony, il mago Zurlì, il parrucchiere Pino o le capuzzelle dei bambini dello zecchino d’oro.
Costoro poi vanno a rampicarsi su un immaginario, che visto da fuori potrebbe apparire illogico, irregionevole, ma che ha una sua coerenza interna. Il termosifone e i suoi fratelli segnano e sognano in realtà uno sblocco e un cambiamento molto forte per la mia, come dire, vicenda dal punto di vista linguistico. Ecco, ho cominciato a scrivere, per esempio, fortissimamente in rima, ossessivamente in rima, ossessivamente ‘male’, però dentro una dimensione di contraffazione, sia dell’immagine sia in particolar modo della sua stagnazione sonora, del suo rigurgito acustico.
Questo è quello che accade, poi il risultato ovviamente non è di mia pertinenza, se non come lettore. Il lettore è colui amministra e custodisce il delirio, diciamo così.
Devo distinguere, diciamo, la cagata dalla cosa invece ‘seria’, non è detto che poi prevalga la cosa ‘seria’. Ma qui è come entrare in un sacrificio a cui non si è stati invitati. Un’illusione vacua.
E tu riesci a distinguere se hai scritto qualcosa di buono o una cagata?
Sì. Sì. Immediatamente, quasi. Sono innanzitutto un lettore senza requie da 50 anni, e ne ho 60: 50 anni da lettore, e una volta anche studioso molto agguerrito. Quindi ho una forte capacità di distinguere.
Poi è ovvio che la riflessione, la discrezione, lo strabismo vanno messi all’opera o all’operetta (o all’indice, se proprio volessimo). La finitura va fatta a freddo (e qui faccio intervenire una delle mie fragranti personalità trinitarie) perché poi deve funzionare un orologino, dal mio punto di vista, ma con la consapevolezza che far funzionare troppo, pretendere di far funzionare troppo un testo poetico è un grave errore, perché poi il testo deve, in qualche modo, saper trovare un’armonia al proprio sciancamento.
Non è detto che il lavoro di rifinitura potenzi o migliori il testo.
Perché, come dire, il termosifone parla come dice lui, non come dico io. E allora lì bisogna avere una certa abilità a mettersi da parte e servire il termosifone, fargli da servo. È un gioco molto complesso, sottile, non sempre riesce, però sì, così posso distinguere la cagata o la supercagata. Perché tale è la nostra vita fecale.
Poi, la mia, come dire, pudicizia, in fase di composizione e montaggio di un intero libro, mi dice che quando non sono certo di un testo, il testo va sacrificato. Non lo sto a modificare. Vuol dire che quel testo non arriva a funzionare con il resto del libro e quindi la cosa più semplice è toglierlo e vedere come si ricombina la cosa, insomma. Perché io, tra l’altro, non scrivo poesie singole. Ma per sequenze. Quindi parto con una cosa, un pupazzetto e devo esaurire tutto il discorso su quel pupazzetto, su quella cosa.
Appunto, non prestabilisco quando finisce, ma capisco quando si è esaurita la potenzialità di quella immagine, di quella possessione, ecco, diciamo così.
Quando leggi, mettiamo, la poesia di uno sconosciuto o di un altro, cos’è che ti fa distinguere se ti piace o meno?
Faccio degli esempi, come dire, ci sono poeti a cui io sono, ovviamente, legato, cioè che considero poeti che mi conducono, mi assistono, mi badano quotidianamente a che io non mi comporti male. E sono anche i più diversi fra di loro.
In realtà, questi sono modelli assoluti. Ultimamente riesco a giocare con loro, parodizzandoli, facendo dispetti. Usandoli scolasticamente, ma proprio per arrovesciare quello che sto dicendo io e quello che stanno dicendo loro. Ci sono, invece, sono attirato, e quelli funzionano, da scritture non intenzionalmente letterarie, né poetiche. Cioè, a volte mi capita di leggere cose stranissime, articoli di giornale o, che ne so, sono interessatissime, le vite dei folli, dei santi, dei pazienti psichiatrici, dei bambini autistici, degli artisti brut, che dicono e disegnano anche linguisticamente universi perfettamente coesi e funzionanti. A volte vengo catturato da alcune sequenze di parole, in modo improvviso; o da rime sbagliate, incongrue – e via parte la macchinetta.
Tutto questo genera, mette in moto una serie di domande. E di risposte sbagliate, che poi sono quelle che preferisco. Quindi ci sono scritture che io leggo ormai perché so che qualcosa lì mi attende, ma in modo imprevedibile rispetto alle mie attese, per così dire, poetiche.
Cioè, vado lì e so che mi devo bagnare in acque non confortanti, che mi afferrano e mi sospendono su una cosa che io non conosco, non controllo.
Mi è capitato di costruire a volte delle sequenze su degli errori di scrittura che ho fatto io.
Cioè, ho scritto una parola sbagliata (e io scrivo a mano, a letto, non in un’altra posizione). Ho scritto una parola sbagliata, con un refuso e quella parola resta a fare da tintinnabolo finché non esaurisce il suo potenziale rifiuto a farsi scrivere correttamente.
Scrivi a letto?
Sì. Diciamo, soprattutto ormai in uno stato di… diciamo di presonno, mettiamola così, adiuvato da divinità Morfiche (e qui parte la preziosissima crasi), perché lì non ho più il controllo di niente. Sono solo nella mia infinita solitudine prostatica. E prostrato al volere altrui.
Una volta ho scritto chiechi, la parola era ciechi, e io ho scritto chiechi. Ora, il rumore di quell’h in più è diventato fonte di un movimento, di una sequenza poetica, in una sorta di lotta al buio tra i ciechi e i chiechi. Quell’errore non l’ho considerato un errore, ma, come dire, una presenza che si è introdotta, a suo agio. E che andava onorata.
Hai amato i surrealisti?
Eh… no. Eh no, perché mi facevano pensare all’inconscio. Sembrerà strano. Perché probabilmente sono pratiche che io costeggio ignorandole. Non mi hanno mai colpito davvero. Per me Dante è il vero allucinato, e il poema dantesco è il più geometrico delirio mai scritto e visto e immaginato. È Dio che ha preso l’Aulin a manetta (e poi l’ha consegnato a Pascoli).
E quanto più lo leggo, più scopro tutte le, come dire, coincidenze, le risonanze, le infinite risate che quest’uomo si è fatto scrivendo la Comedia o Comedìa. Come Dia (che Dia è la trinità femminile che tutta ferve per il poeta). Però questo non mi fa mai pensare a un’orologeria ferma, non so come dire, ma a un’orologeria che è pronta proprio nel testo a stravolgersi, ad andare in retromarcia, in controtempo. Dante non predefinisce niente, paradossalmente. Tutto ciò che è predefinito rispetto all’azione poetica rende la poesia fasulla o fasulla la teoria.
Si ricava qualcosa di teorico, se proprio, dopo, post factum. A reato commesso.
Mi sembra che, nel tuo approccio alla scrittura, sia fondamentale il saper ascoltare, il saper entrare in contatto con le cose. L’ispirazione è questa?
È la camera acustica dentro la quale io vivo fondamentalmente, che è veramente popolata da qualsiasi cianfrusaglia umana e non.
Quando poi, diciamo, riesco a fare silenzio di me stesso, allora inizio a registrare. Proprio come le radioline che volevano captare e poi registrare gli ectoplasmi che parlavano, insomma. Il problema è che devo fare silenzio io. Devo silenziare me stesso.
La mia parola stessa la devo silenziare. Cioè il mio modo di impostare la frase per ascoltare. Poi è chiaro che, diciamo, da un lato sono posseduto da Topolino, dall’altro, l’ultima voce la metto io (o chi per me – oh chi per me), una voce fasmide che però non si sovrappone al testo ectoplasmatico. Nessuno vuole morire e dunque tutti si mimetizzano con tutti.
C’è un’organizzazione. Poi. È la disposizione dei testi su cui io agisco di più. Più che sul testo singolo.
Ti riferisci alla sequenza di cui parlavi prima?
Sì, sì. È l’ordine, la trama, che mi interessa perché poi attraverso l’ordine e la sua frizione si crea tutta un’altra serie di possibilità.
Quindi le risonanze avvengono nel momento in cui cominci, come dire, a combinare gli elementi. Un’altro punto di cui vorrei chiederti è il tuo amore per Dante. Dante è, senza dubbio, un gigante. Però lui è molto rigoroso: usa l’endecasillabo, usa la rima, ma tutto questo è anche artificiosità.
Sì, sì, certo. La dimensione della, chiamiamola così, artificiosità non mi fa paura. Io sono sostenitore delle gabbie, delle camere di tortura in termini poetici.
Lo sforzo di stare dentro una gabbia, che sia una struttura (sonetto, madrigale, settenario novenario o decasillabo, o quello che è) o semplicemente la rima, per me, è potenzialmente più stimolante e molto più liberatorio che il non concederseli – la gabbia e lo sforzo. La gabbia, il lettino di contenzione sono il mio giardino dei supplizi. Meravigliosi e tenerissimi quelli di Pascoli e Gozzano, ad esempio.
O quello leopardiano: “Entrate in un giardino di piante, d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite stagione dell’anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in istato di souffrance, qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce”. La souffrance, che meraviglia! La souffrance della gabbietta: è la poesia stessa.
E ovviamente diciamo che il mio divertimento massimo è questo. Trovare la rima, e se non c’è, all’uopo se ne crea una, foss’anche sbagliata e indecorosa.
Cioè, mi deve tornare la rima. Quindi è la rima che mi conduce, non il significato di quello che sto dicendo. Né un senso purchessia. Mi intrippo e mi inveschio su una sequenza di rime, e devo procedere fino a che non esaurisco la sequenza di rime.
Quello che c’è dentro, paradossalmente, si costruisce, diciamo così, a partire dalle rime. Non c’è una pre-intenzione. Non so mai dove il testo e la testa vanno a parare. E dentro questo mondo falsovero di suoni fanciulleschi e colpevoli di esistere, compaiono personaggi, a volte diversi, che continuano però a ripetere le stesse cose. Ovviamente sto dentro il mio mondo. Come dire, c’è un mondo di vivi, di morti, di gente che non si sa più dov’è, di non-nati.
Ma sono altri personaggi inseriti in un’altra vicenda, in un’altra cosa. E cambiando il personaggio, comincia a cambiare tutto il resto. Il non sapere dove si è, chi si è, perché è, Dio, la teologia e ciao e ci vediamo.
Però se lo dice il professor Tamburello, o il chieco o lo dice Caldarella, che è quello dei termosifoni, si tratta di scenari completamente diversi, di gradi diversi del Paradiso.
Cioè, detto da uno o da un altro, e soprattutto da un dove diverso, le cose cambiano. Davvero, in gli ultimi tre anni mi diverto, che rido da solo – all’apparir del vero.
Questo tuo modo di operare è sempre stato così o è cambiato nel tempo?
No, no, è questo che dicevo. Tu giustamente coglievi, diciamo, il passaggio dal freddo al caldo.
Il registro basso-comico, diciamo così, chiamiamolo in questo modo, è recente. È come se io, in parte lo è, mandassi a quel paese me stesso di prima o riadottassi il fanciullino ch’era in me quello satirico, epigrammatico, predicatorio. Insomma una saturiasi terminale.
Ma sai, Vito, forse invecchiando si diventa più comici.
Sì. I freni inibitori saltano, l’educazione salta, l’educazione anche linguistica, e quindi si comincia a sragionare, almeno questo è davvero così, è vera questa cosa. E soprattutto si finalmente, finalmente, si arriva a un punto in cui l’io, se stessi, il non-io, il non-tu, l’egli e l’eglia, e simili ‘altezze’ non hanno più senso; non so come dirlo, non c’è più niente da difendere, perché non c’è mai stato niente, ma in qualche modo uno ha sempre creduto di difendere qualcosa di sé, del proprio lavoro, senza sapere cosa e perché.
Io non difendo più niente, non ho più la dignità di uno che si sta difendendo, tanto meno quella di uno che sta affermando una sua non si sa che cosa. Il suo più che mai raffinato nulla a procedere.
Ecco, insomma, in un certo senso, sì, è proprio un lasciarsi andare, o un lasciare andare sé stesso,
dove vuole andare lui e prendere una strada, di uno che è senza terra, senza io, senza senza, in cui affiora quello che deve affiorare, non c’è rito, non c’è vergogna, solo una suprema e delicatissima castità, ecco.
Beh, Palazzeschi ha aperto le porte…
Eh, benissimo, perfetto. E quindi in realtà, insomma, poi mi diverto a prendermi in giro io, vabbè, ma sì, mi diverto a riscrivere le cose poetiche, mi sono divertito a riscrivere due volte, o tre addirittura, La pioggia nel pineto di D’Annunzio, ma nella riscrittura della riscrittura montaliana. Mi divertiva anche tenere uno schema, diciamo, abbastanza dannunziano, ma mettendo dentro uno di Foggia (io sono di origini Foggia, quindi…). Prima non lo ritenevo, diciamo così, poetico, poetizzabile, questo figuro di Foggia. Invece mi è sembrata decisiva l’immagine – lì era l’universo, cioè mettere uno di Foggia dentro una pioggia nel pineto post-montaliana, scritta da un deficiente (ovvero moi) ma con una, come dire, dimensione teologica addirittura. Proprio laddove si comincia a avvertire una certa incontinenza senile, nobilmente trasfigurata.
La vita felice
chi ti parla – caro lettore –
è il salvavita beghelli
ovvero l’oblio
la dimenticanza
l’estrema infanzia
di beato-allùi
fui donato alla sua nascita
e sono il suo rosario
l’angelo tuo
obituario
il falso allarme
il pulsante rosso
l’apocalisse il calvario
di chi visse
tra le stelle fisse
et un sudario
il niente forcluso
l’opacità
il monouso
che mai vide l’aldilà
[…]
che? non ti piageva
la smisurata tua doglianza?
la buia lontananza?
la bua senza speranza?
il fior che fragile morì
tra gli usignuoli già in ardore?
non è abbastanza
questo papaverico tremore?
cos’è che non sai?
o è perché te ne vai e vai
e vai alfin laggiù
tra i rrasoi
che rrose non furono mai
luce morte dondolio
oh sine fine addio
beate rrime addio beate
mai state mai neppure nate
voi
spente lampadine
io fervente
senza mutandine
da Acrobeati (2023)