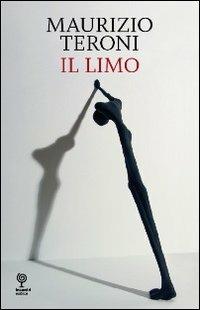Alberto Bertoni (Modena, 1955) insegna Letteratura italiana contemporanea nell’Università di Bologna. Come critico ha curato l’edizione dei Taccuini 1915-21 di Filippo Tommaso Marinetti (il Mulino, 1987) e, oltre a numerosi altri saggi di argomento novecentesco, ha pubblicato i volumi Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero italiano (il Mulino, 1995) e Una geografia letteraria tra Emilia e Romagna (CLUEB, 1997, insieme con Gian Mario Anselmi). Sul versante poetico, a partire dal 1986, ha svolto una costante attività di performance in collaborazione con il poeta modenese Enrico Trebbi e con il saxofonista jazz Ivan Valentini, realizzando con loro, nel 1997, il libro+CD La casa azzurra (Mobydick). In proprio ha pubblicato i volumi Lettere stagionali (Book, 1996, Premio Caput Gauri 1996 e Premio Dario Bellezza 1998); Tatì (Book, 1999); Il catalogo è questo. Poesie 1978-2000 (Il cavaliere azzurro, 2000); Le cose dopo (Aragno, 2003); Ho visto perdere Varenne (Book, 2006) e Ricordi di Alzheimer (Book, 2008); Il letto vuoto (Aragno, 2012); Poesie 1980-2014 (Aragno, 2018); L’isola dei topi (Einaudi, 2021); Culo di tuo mamma. Autobestiario 2013-2022 (Samuele Editore, 2022). Sulla sua poesia hanno scritto tra gli altri Giovanni Giudici, Raffaele Crovi, Niva Lorenzini, Gianni D’Elia, Elio Tavilla, Salvatore Jemma, Vito Bonito.

Teroni
Buongiorno Bertoni. Lei è sia critico sia poeta. Dovesse delineare un quadro della poesia attuale, cosa direbbe?
Bertoni
Prima di rispondere puntualmente, devo fare una premessa, che non riguarda la mia esperienza soggettiva, ma la situazione antropologica nella quale vivono attualmente testi letterari all’interno dell’attuale civiltà occidentale. Senza voler essere a ogni costo millenaristi o apocalittici, il problema meno facilmente risolvibile, oggi, è proprio questo: il leggere come tecnica, necessità vitale, passione, cognizione, forma di educazione minima, acquisizione di memoria costituisce una pratica e un traguardo sempre più aleatori, illusivi, irraggiungibili. Per cause anche sociali, esterne: i libri di poesia contemporanea sono difficilissimi da reperire in una libreria “normale”; l’immagine pubblica del poeta non ha la minima possibilità di incidere su quello che è il pur risicatissimo contesto di dibattito culturale e civile; la scuola dovrebbe decidersi a decidere se la poesia degli ultimi cent’anni fa parte o no della formazione linguistico-letteraria da impartire a un adolescente, a un certo punto del suo Bildungsroman; le crisi convergenti e interdipendenti della storia e della memoria collettiva prima ancora che individuale non sono favorevoli a una ricezione motivata e profonda delle spesso contrapposte visioni del mondo che suscita la buona poesia “scritta”.
Riguardo la scuola, insegnando vedo che, a parte rari casi, la scuola è fossilizzata sui programmi che non variano granché da 50 anni fa. Ma forse il problema di base è proprio che siamo meno in grado di leggere, ovvero di saper stare sul testo.
È evidente a ciascuno di noi che esistono oggettivamente uno spazio e una motivazione sempre minori per la lettura solitaria e concentrata, fondata su uno scopo precipuamente conoscitivo, nelle giornate di lavoro, nei dibattiti politici e sociali, nei periodi di vacanza, per non parlare dell’accoglienza che la poesia riceverebbe nelle discussioni pubbliche o amichevoli. Anche a rimanere ancorati al suo contesto, infatti, è facile notare come tutti (e non solo gli o le implumi esordienti, tra adolescenza e giovinezza, come potrebbe anche esser naturale) tendano a chiedere lettura – attraverso i social-media non meno che di persona – e mai a offrirla, se non nella prospettiva strumentale di leggere per esser subito a propria volta letti.
Ovviamente questa crisi epocale del “saper leggere” si riflette su quella forma di lettura specializzata e “profonda” che è la lettura critica, oggi rigidamente spartita fra una critica accademica (svolta cioè in sede e con finalità universitarie, in chiave tanto didattica quanto di posizionamento “scientifico” all’interno dell’istituzione); e una critica militante e/o pubblicistica (sul web, non più o pochissimo su carta stampata).
In un contesto di questo tipo, come può porsi l’analisi critica?
Alla luce di questi presupposti, la critica della poesia è cambiata nel senso che la poesia è diventata un fenomeno diffuso dove alla lettura si è sostituita la scrittura, un brulicare inarrestabile di testi che occupano una sorta di palude o il terrain vague di un mondo frammentato, tutto esteso in orizzontale dove è molto difficile creare connessioni, rapporti, genealogie e dove questo stesso impegno non ha più senso perché appunto è mutata ontologicamente l’interlocuzione profonda della parola poetica. Dentro una parvenza di “società poetica stretta” in senso leopardiano come si è data in Italia nei decenni fra il secondo dopoguerra e gli anni Settanta del Novecento, infatti, il circuito editoriale e conoscitivo della poesia prevedeva l’esistenza materiale di un gruppo se non di un canone di autori più o meno socialmente riconosciuti; della loro storia e delle loro opere necessariamente in progress oltre che dettate da poetiche (e visioni del mondo) non di rado in conflitto fra loro; e infine di un pubblico, vale a dire di un orizzonte di voci e di coscienze predisposte a lasciarsi attraversare e coinvolgere intellettualmente e fisicamente in quel testo, per sviscerarlo e – criticandolo – per collocarlo dentro un orizzonte storico e di senso, dunque – etimologicamente – per comprenderlo: ebbene tutto questo meccanismo non agisce più e per diretta conseguenza non esiste più nemmeno più una critica di poesia che non sia episodica (non importa se in forma elogiativa o polemica).
E secondo lei, in un contesto simile, che spazio può avere la poesia?
C’è un proliferare di scritture poetiche, ma la critica non marcia più in parallelo per assenza di spazi e di interesse pubblico. La sua funzione e la sua pratica sono paradossalmente venute meno proprio quando il molto di buona poesia che viene prodotto in Italia avrebbe bisogno di più critica e non di meno critica (naturalmente militante); e avrebbe anche bisogno di coscienze che si impegnassero seriamente a giudicare un libro, a discernerlo, a capirlo, a creare un rapporto genetico fra l’orizzonte storico che l’ha prodotto e quello della sua lettura – magari smontandolo nelle sue varie componenti formali e simboliche. Un buon libro di poesia impegna molto la coscienza di ogni critico serio, onesto e davvero preparato, perché lo obbliga a scavarne e interpretarne la radice linguistica e quella di pensiero (fra tòpoi e fondamenti conoscitivi), nonché il tono e l’orientamento comunicativo, percependone i valori integrati e riconoscendone la visione del mondo, accanto agli eventuali difetti compositivi e strutturali. Il problema è che non ci sono più interlocutori: così, non essendoci più interlocutori, non ci sono più spazi di diffusione per una siffatta parola critica, che sarebbe invece quanto mai necessaria. La forma del saggio di critica letteraria come abbiamo imparato a concepirla noi negli anni Settanta (anni di teoria più che di pratica, di linguistica più che di storicismo) non attecchisce più nel terreno dei potenziali lettori di oggi: i miei studenti restano spiazzati di brutto davanti all’idioletto e alla complessità argomentativa di un saggio sulla poesia scritto secondo i crismi novecenteschi. Oggi nutro molta fiducia – continuando pervicacemente a credere nell’importanza fondamentale dell’atto critico – in forme più “liquide” d’intervento critico quali il commento e l’intervista.
Sempre rimanendo nel binomio “critico” e “poeta”, ho una curiosità: come ha vissuto negli anni questa, diciamo, dicotomia?
Devo premettere che l’Università tollera a fatica che un suo docente sia anche scrittore in proprio. Io per di più vengo dalla Bologna degli anni ’70, dove teoria, ermeneutica, sociologia, semiotica prevalevano per così dire onotologicamente sulla scrittura creativa che – in ogni caso, qualora venisse praticata – doveva rispettare le regole schizomorfe, antiliriche e distruttive verso qualsivoglia sospetto di armonia metrico-linguistica praticate dagli autori della Neoavanguardia. E così sono diventato un critico-professore, attività nella quale sono molto più bravo che come estensore di versi e che mi ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto nella parte dell’attività didattica.
Da quasi subito, in effetti, a mia “carriera” universitaria (che sarebbe cominciata professionalmente nel gennaio 1993) mi ha portato molto lontano dalla pratica poetica, nel senso che mi accingevo a diventare un docente e uno studioso, che si trovava a percorrere le strade della sistematicità, di una letteratura non più solo storica ma anche geografica, delle tecniche più avanzate del formalismo e della linguistica applicate a testi che erano tanto più credibili quanto più venivano da autori o da autrici morti e perciò già consegnati a una nobiltà compositiva in certa misura incontrovertibile: dei classici, insomma.
Lei è stato allievo di Ezio Raimondi. C’era un contrasto tra il rigore accademico e la tensione militante, che mirava, in particolare negli anni Settanta, al rifiuto di una certa impostazione?
La letteratura di Raimondi non era una letteratura militante anche se io praticavo già la letteratura contemporanea. Con lui ebbi anche delle discussioni, in materia: il mio interesse per la metrica gli faceva piacere, ma gli sarebbe piaciuto che cominciassi a studiare – prima del verso libero – l’ottava nei suoi meccanismi anche più segreti, fra Ariosto e Tasso. Così, cominciai una ricerca specifica sul valore e la funzione di emblema visivo-visionario del distico a rima baciata che suggella l’ottava narrativa “classica”, ma in cuor mio mi sentivo molto più vicino al mondo della militanza contemporanea e al gusto novecentesco: tanto che abbandonai quasi subito quella ricerca e rafforzai piuttosto lo studio del verso libero.
E quali erano gli autori che la interessavano in quella fase?
Con quella decisione mi conquistai anche la scusa scientifica per leggere in modo meno rapsodico i poeti che mi permettevano di riunire memoria e passione, cultura letteraria ed esperienza diretta della parola poetica: dopo Gozzano, Saba e Montale, Vittorio Sereni, Giovanni Giudici, Luciano Erba, Nelo Risi, Giovanni Raboni, quelli, soprattutto, che si distinguevano nella “linea lombarda”: esponenti, dunque, di una poesia responsabile di sé che mostrava anche qualche apertura civile, sulla scia di Parini e di Porta, non rinunciando a una certa dolcezza di fraseggio e a una certa capacità musicale nel raccontare quelle stanze di vita quotidiana che assumevano talvolta la parvenza di vere e proprie microstorie o esperienze di vita vissuta, nella direzione di una metafisica in rapporto con il trascendente. Giovanni Testori, scandalosamente rappresentato a teatro, un altro. A questi aggiungevo anche autori di una generazione più giovane, Maurizio Cucchi, Valerio Magrelli e più di lato Milo De Angelis, perché un certo suo radicalismo mistico – per fortuna combinato con una Nuova Oggettività tutta originale – infastidiva la mia laicità, allora più intransigente di quella che continuo a professare oggi.
Da una sua intervista emerge una sorta di imbarazzo, almeno in gioventù, tra la figura del critico e del poeta. Se permette, vorrei mettere il dito nella piaga di questo ipotetico imbarazzo. Lo ha superato? E se sì, come?
Venendo all’elemento puntuale e autobiografico della domanda: sì, per lunghi anni la convivenza fra insegnamento universitario, lavoro critico (mai troppo militante, però, oppure militante solo nella dimensione delle presentazioni orali di libri e autori/autrici) e scrittura poetica è stata difficile e controversa. Non di rado, mi sono sentito dare del “poeta” in ambito universitario; e dell’ “accademico” (termine che aborro) in ambiente poetico. Con l’irrompere del nuovo secolo, con il progressivo sovrapporsi e convivere delle diverse maschere da assumere di volta in volta nel contesto umanistico così come si presenta in Rete, le distanze, le differenze e le relative difficoltà di rapporto fra le tre attività da me svolte in sincronia si sono molto affievolite e assottigliate. Oggi che sono vicino alla pensione sono pressoché inesistenti, anche se io – per mia individuale scelta etica – non parlo mai a lezione del mio lavoro poetico, anche se so benissimo che gli studenti cercano i miei testi creativi e in certi casi perfino li leggono, credo e spero con contenuta ironia (che io nel profondo apprezzo).
Da quanto sto deducendo in questi dialoghi con poeti, mi pare che si possano delineare due fondamentali impostazioni dello scrivere: uno che è più mirato all’aspetto retorico linguistico, l’altro che mira maggiormente al contenuto. Diciamo una linea più cerebrale e una più emotiva. Cosa pensa di queste due ipotetiche linee? Pensa che sia una divisione sommaria o che in effetti vi siano due forme di tendenze?
Confesso che in poesia non amo troppo schemi e dicotomie. Ogni vera poesia di ogni vero/a autore/autrice ridisegna e fa interagire a modo suo i diversi piani espressivi, metrico/ritmico, retorico, intonativo, linguistico, storico e stilistico di cui si compone e si avvale un testo. Oggi, attraverso le innumerevoli scuole di scrittura creativa che si diramano in Rete, è per esempio di moda l’imperativo formulato in inglese (che accomuna il genere narrativo e quello poetico) Show, don’t tell, cioè Fa’ vedere invece di limitarti a dire. Ma non può essere stabilito a priori che questa formula ti apra automaticamente mondi compiuti e perfetti sul piano letterario. Certo, i fatti e le componenti formali di una poesia – per quella che è stata la mia formazione e per quello che anche oggi è il mio gusto – sono delle dominanti decisive; tuttavia, anche i paradigmi tematici hanno un rilievo non cancellabile solo perché una buona poesia contemporanea, a sentire certe teorie sperimentali, deve impedire la comprensione rapida di quelli che un tempo si chiamavano contenuti. Non si deve dimenticare che ogni testo poetico è prima di tutto un messaggio linguistico rivolto da un essere umano a un’altra coscienza non meno umana, predisposta per decodificarlo e rispondergli. Perciò credo fermamente che pensiero e pathos, razionalità ed emotività, debbano trovare – soprattutto in poesia – un equilibrio dinamico in quanto non definito una volta per tutte, ma ricostruibile e ricaricabile ad ogni nuovo atto di lettura. Le poesie che rimuovono in partenza l’aspetto tematico mi coinvolgono poco: e credo che il Senso complessivo di un testo derivi dall’interazione produttiva e sempre in progress fra le diverse componenti linguistico-formali e i referenti “logici” degli enunciati verbali (grammaticali o antigrammaticali che siano), tenendo conto delle variabili storiche, psicologiche, culturali che creano il cortocircuito comunicativo fra chi quel testo ha scritto come una partitura musicale e chi lo decodifica e lo acquisisce al sé più profondo, introiettandolo e facendolo scorrere attraverso la propria voce interiore e la propria immaginazione.
Per concludere, le propongo “Il gioco della torre”. Ipotizziamo che le sia stata commissionata una storia della letteratura in cui, per problemi di spazio, deve trovarsi a scegliere se mettere Nanni Balestrini o Elio Pagliarani. Chi sceglie e perché?
Non ho dubbi: metto Nanni Balestrini, che ha composto un’opera davvero polifonica, riunendo alla poesia una notevole scrittura narrativa e critica, oltre che un’attività di artista figurativo e performativo tutt’altro che disprezzabile (oltre al fatto che il suo testamento poetico, Caosmogonia, è un libro semplicemente bellissimo). Pagliarani, malgrado lui, è l’autore di un grande poemetto come La ragazza Carla, ma il resto della sua produzione inventiva non ha mai più nemmeno sfiorato quell’isolato vertice.
Metamorfosi
Una delle prime cose che farò
quando tutt’e due saremo alberi
sarà dimenticarti
ma senza whisky e senza psicoanalisi
No, saprò dimenticarti
donando le foglie più casuali,
ribelli, irregolari
alle schiere di passeri sui rami
e – vedrai – saprò dimenticarti
come ho già dimenticato
gli immani soffi atlantici
le diastoli e le sistoli del mare
che si tende o si apre
di sei ore in sei ore
così che ogni giorno quattro volte
avanza e si ritira
Io e te con le facce come
cortecce di rughe,
buchi da sembrare tane
e radici del buio più profonde
io e te saremo entrambi bravi
a dirci come siamo stati
portatori nel complesso sani
d’abbandoni e resistenze
E così, rimanendo tali e quali,
fruste di salici, ali
potremo all’infinito ricordarci
(da L’isola dei topi – Einaudi, Torino 2021
Nel cretto di Burri
Ad aprire l’ombrellino a Selinunte
nell’acquivento che c’inquieta e ci solleva
le scateni per forza, amore mio
le terribili potenze ctonie
e marine
di Giunone, Poseidone o chi per loro
a frustare i pori della pietra
di pioggia combinata con il mare
senza chiedere il parere del buon senso
che ci scorre nelle vene
e si stampa sui volti
ricoperti dal panno guerriero
degli inverni padroni
Ma che figura d’imbranati
e peccatori implacabili di hybris
noi due, celti padani
alle prese con le furie scatenate
dei ciottoli in volo fra i cespugli
incatenati da sempre
e per sempre alla preistoria delle nostre
terremare palafitte fragilissime case
ancora costruite sugli alberi
e così estranee a questi
burroni o saliscendi
di forre arbusti nascondigli
qua dove passano le piste
strettissime di capre
che senza parere ci spalancano
il mondo dei morti
E senza più voce ti fanno
parcheggiare a margine
arrampicarti su planimetrie
e ferite immedicabili
nel cretto di Burri