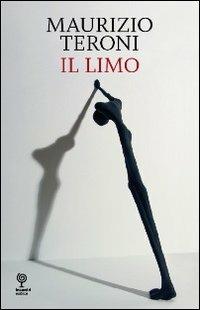di Dario Meneghetti

Favolosi anni Ottanta. Andava tutto bene, o andava bene tutto, tanto era uguale. Il rapporto allievo insegnante era super confidenziale, per un certo periodo fu permesso fumare in classe, l’ora di religione diventava facoltativa quindi inutile, la moda era femmina, gruppi cometa come i Men at Word e i Talk Talk graffiavano veloci il firmamento musicale, altri come i Culture Club e i Bronski Beat facevano outing abbattendo a suon di musica il muro omofobo del perbenismo ipocrita dell’Inghilterra piccolo borghese. Duran Duran e Spandau Ballet dividevano il popolo dei giovani – adesso cinquantenni – come i Beatles e i Rolling Stones. Io mi buttavo di pancia rotolando e scalciando come un tarantolato al grido di “Valeboise, valeboise” (Wild boys, wild boys), la famosa canzone dei Duran Duran.
Si respirava un’aria di relativo benessere trasversale a tutte le classi sociali, sembrava essercene per tutti, l’Italia diventava la quinta potenza economica e l’inflazione era più che dimezzata, in più i salari aumentavano e con loro la capacità di spesa. Tutti andavano in giro con roba firmata citando Il Capitale di Marx senza averlo mai neppure visto, nessuno si accorgeva che era tutto finto e che il debito pubblico diventava un mostro autofagocitante. Era il tempo delle cicale, l’Italia friniva al vento caldo di quella primavera economica, si crogiolava nell’illusoria favoletta raccontata dalla politica, rifiutandosi di guardare in faccia la realtà dei dati macroeconomici, chiudendosi in una sorta di nichilismo negazionista o di cecità isterica.
Si stavano gettando le basi di un disastro, quello che sarebbe poi esploso nella famosa tangentopoli degli anni Novanta, ma questo nessuno poteva o voleva presagirlo, io meno di tutti. Continuavo ad avere la coscienza politica di un batterio, e ne andavo fiero. Per questo non scioperavo mai. Ero coerente, onesto nella mia insipienza. Mentre gli altri scioperavano per qualsiasi cosa, dalla carenza di cancellini al diritto ai cinque minuti in più di intervallo, io stavo in disparte a osservare, pensando tra me e me: poveretti, tutta sta pantomima per qualche ora d’aria. In effetti non avevo certo bisogno di scioperare per non andare a scuola, ma almeno non fingevo di essere politicamente impegnato e di capirci qualcosa, come facevano tutti o quasi. Schiere di adolescenti male indottrinati a cui domandare il motivo dello sciopero era imbarazzante. Ma questo è sempre stato e sempre sarà. A volte qualcuno provava a sondare la mia posizione riguardo a questo o quell’argomento politico, pensando che ne avessi una, ma io tagliavo corto, non lasciavo mai neanche finire la domanda. “Non so, non me ne intendo di calcio” e “mi sparo mille seghe al giorno”, di solito chiudeva l’argomento.
Non ero un secchione, è vero, ma anche a esserlo sarebbe stata dura, il liceo musicale più il conservatorio erano una condanna, un putiferio di materie che occupavano un’intera giornata. Il liceo, un mix tra classico e linguistico, poi al pomeriggio le materie musicali: strumento principale, secondario, teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, arte scenica, e canto corale.
Vedendomi sconfitto in partenza, preferivo formarmi il fegato in previsione di un futuro a base di Bitter. Anche Beppe era un artista del disimpegno scolastico: non studiava, ma con classe.
«Barutti, mi faccia un diagramma spiegano il rapporto tra x e y».
«Sì, ecco professore, ho studiato tantissimo, so tutto, vede… qui la potenza di x fa una parabolica», e disegnava una curva con sicumera, «qui quella di y ne fa un’altra» altra sferoide, «la risultante è questa», e disegnava una “u” molto stretta e lunga. Il prof restava basito mentre la classe si rotolava dalla risate di fronte alla rappresentazione di un cazzo gigante.
Tra una manca, giornata di scuola saltata a piè pari, e una fuga dal gatto-prof di lettere, sovente, sempre durante l’oratorio di liceo, mi piaceva frequentare canto corale, cosicché era come autodenunciassi la mia assenza ingiustificata, ma non me ne importava nulla, a quel punto avevo guadato il limite delle dinamiche scolastiche, mi autogestivo, vivevo un universo parallelo. I professori non dicevano più nulla. Tutto sommato canto corale era sempre meglio che il bar da Gino.
Con l’inizio degli anni Ottanta terminava l’esperienza del movimento operaio, una delle poche realtà davvero utili al progresso sociale e alla conquista dei diritti dei lavoratori di quel decennio di ammazzamenti, bombe, stragi e sterile giustizialismo ideologico. I giovani reazionari di quel periodo che protestavano più o meno contro il sistema e contro i loro stessi genitori, erano ora genitori a loro volta. Senonché, rifiutandone il ruolo in senso tradizionale, invertivano la classica dinamica figlio-rivoluzionario genitore-conservatore, generando un gap generazionale tra padri e madri che non volevano esserlo, e figli che figli non erano. Quei figli-non figli eravamo noi, incapaci di fare da genitori a noi stessi, in alcuni casi, non il mio, lo si doveva essere dei propri genitori. Questo non ha portato che incomprensione e impossibilità di relazionarsi, tutto per quella mania di anteporre l’ideologia al buonsenso, che ciclicamente si ripropone creando lo sfacelo sociale. Non a caso il Rinascimento c’è stato quando il Papa era ad Avignone.